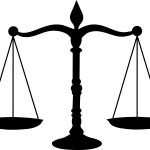 L’attività di direzione e coordinamento (D&C) è stata introdotta nel Codice Civile, dall’art. 5 del D. Lgs 17/1/2003 n. 6. Di norma, la fattispecie evoca il “gruppo” societario, ossia una realtà complessa ed articolata nella quale, in diverse forme, più società agiscono in modo tra loro coordinato.
L’attività di direzione e coordinamento (D&C) è stata introdotta nel Codice Civile, dall’art. 5 del D. Lgs 17/1/2003 n. 6. Di norma, la fattispecie evoca il “gruppo” societario, ossia una realtà complessa ed articolata nella quale, in diverse forme, più società agiscono in modo tra loro coordinato.
Tuttavia l’attività di “direzione e coordinamento di società” può riguardare anche il rapporto tra due sole società e questa circostanza amplia in modo significativo l’incidenza di tali norme sulla realtà del tessuto economico ed in particolare la possibile applicazione della norma cardine della novella sopra menzionata, ossia l’art. 2497 c.c., che disciplina la responsabilità per l’esercizio “abusivo” di tale attività.
Il Tribunale di Firenze -30/12/2024, n. 4164/2024- chiarisce la necessità di un quid pluris richiesto per la configurazione della responsabilità risarcitoria connessa all’abuso.
La responsabilità ex art. 2497 c.c. per abuso dell’attività di direzione e coordinamento presuppone l’effettivo esercizio, da parte della società dominante, di poteri gestionali sistematici e vincolanti, tali da incidere sulle scelte strategiche e operative della società eterodiretta, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, e da determinare un danno diretto e causalmente ricollegabile alla condotta abusiva.
Si considera “dipendenza economica” la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi; situazione da valutarsi tenendo conto della possibilità effettiva della parte contraente c.d. “debole” di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. La mera dipendenza economica – intesa come squilibrio nei rapporti commerciali- non è sufficiente a integrare la fattispecie, né può automaticamente far presumere l’esistenza di un controllo contrattuale rilevante ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 3 c.c.
Il controllo contrattuale rileva ai fini dell’art. 2497 c.c. solo se si traduce in una influenza dominante che priva la società eterodiretta della propria autonomia decisionale, mediante vincoli negoziali “particolari” che condizionano direttamente la sua capacità imprenditoriale. Il quid pluris richiesto dalla norma, nel momento in cui impone che i vincoli contrattuali, oltreché rilevabili in maniera oggettiva, siano “particolari”, invero, consiste nel fatto che, sulla scorta di detti vincoli, la controllata non possa autonomamente determinare le proprie scelte strategiche di gestione in merito allo svolgimento della propria attività imprenditoriale e che, pertanto, l’atteggiarsi dei rapporti negoziali determini una radicale e stabile traslazione all’esterno della società del potere di direzione dell’attività sociale, tale da trasformare Luna società in una sorta di mera succursale dell’altra contraente. In assenza di prova di una tale ingerenza strutturale e di un danno specifico, non è configurabile alcuna responsabilità risarcitoria.
La pretesa risarcitoria fondata su un’allegazione di abuso di dipendenza economica deve essere inquadrata nel regime della responsabilità contrattuale.
